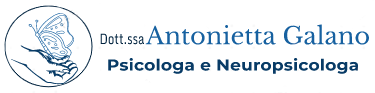“L’amore infantile segue il principio: amo perché sono amato. L’amore maturo segue il principio: sono amato perché amo. L’amore immaturo dice: ti amo perché ho bisogno di te. L’amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo”
Erich Fromm in L’arte di Amare
Quando ci troviamo in una relazione di coppia poco appagante che si trascina nel tempo, facciamo attenzione, potremmo essere incappati in un circolo vizioso senza riuscire da soli a rintracciare il bandolo della matassa, potrebbe trattarsi di un rapporto disfunzionale di dipendenza affettiva.
Per rispondere alla domanda “Come uscire dalla dipendenza affettiva?” proviamo a definire le caratteristiche di una relazione di coppia: esistono tanti tipi di amore e una fase simbiotica, almeno all’inizio, è implicita al rapporto ma quando si prolunga nel tempo ed assume determinate caratteristiche può prendere una brutta piega. Possiamo distinguere l’infatuazione, l’innamoramento, il colpo di fulmine, l’attrazione sessuale, l’amore romantico, l’amore passionale…
Quali sono le caratteristiche della dipendenza affettiva?
Molti autori hanno tentano di definire cos’è l’amore…ma vorrei porre l’attenzione su quando e come una relazione amorosa (e non solo) diventa patologica e nociva per i componenti:
-
Quando viene meno la RECIPROCITA’: uno dei due membri investe più energie dell’altro, senza essere ricambiato come vorrebbe o come si aspetterebbe, tende ad idealizzare l’altro che spesso si presenta in maniera sfuggente e non disponibile, in parole povere vediamo uno dei due componenti della coppia in una posizione di inferiorità e debolezza psicologica che elemosina le attenzioni dell’altro, quest’ultimo a sua volta, non desidera ricambiare le attenzioni e percependo le fragilità del partner, si mostra sicuro di sé, con un Io forte e ben saldo. Siamo di fronte quindi ad un rapporto in cui l’immaginario dei partner non è speculare ma sbilanciato a favore di uno dei due componenti della coppia.
-
La relazione di conseguenza non è più il LUOGO dell’intimità, della sintonia, del nutrimento affettivo ma della costrizione, della scelta obbligata, dell’inevitabile, del peso da trascinare… con il tempo, irrimediabilmente, queste dinamiche disfunzionali si ripercuotono sulle personalità dei due membri.
-
Mancanza di CONFINI tra sé e l’altro: lo spazio personale che protegge la propria identità e la propria privacy, è violato dalle incursioni dell’altro che controlla il telefono, manipola le nostre relazioni con colleghi, amici, parenti o tenta di sabotare i nostri progetti.
-
Ricerca continua di APPROVAZIONE e RICONOSCIMENTO da parte dell’altro: si vive in balia delle onde ovvero dei giudizi e dei feedback, si consegnano le redini della propria vita all’altra persona senza essere in grado di gestirsi in maniera costruttiva. In questo modo l’autostima e la considerazione di se stessi ne risente ogni volta che non si ottiene il benestare dall’altro.
Quali sono le caratteristiche psicologiche di una persona che cade nella dipendenza affettiva?
Il vissuto soggettivo del dipendente ha spesso radici nel tipo di relazione di attaccamento instaurata durante l’infanzia con la figura di riferimento principale (spesso la madre) che poi si è consolidato nel corso degli anni diventando uno stile di attaccamento. Queste persone sono perennemente animate dal desiderio delirante di fusione con il partner, lo stesso desiderio inappagato che ha sperimentato da bambino nei confronti della propria madre, quando i suoi bisogni affettivi sono stati trascurati o l’amore ricevuto è stato percepito come inautentico. Di conseguenza, il rapporto di attaccamento con la madre è stato di tipo insicuro, caratterizzato da angoscia abbandonica, paura del rifiuto e del tradimento tanto che la figura di attaccamento non ha costituito nella vita del bambino una base sicura a cui affidarsi e a cui dare fiducia. Con la crescita il dipendente tende a investire più energie del necessario nel rapporto con l’altra persona, tutta la sua vita ruota intorno all’altro che è sovraccaricato di idealizzazioni, di conseguenza ad ogni delusione il rapporto assume la forma del controllo per la paura di essere traditi e abbandonati e il dipendente vive con l’ansia di non essere abbastanza per il partner. In queste condizioni non è difficile immaginare quanto l’autostima della persona dipendente si abbassa ma nonostante ciò la sua personalità disfunzionale gli impedisce di porre fine al rapporto in quanto l’unico modo di essere al mondo è con l’altro, è grazie al nutrimento che gli fornisce l’altra persona e che va a riempire il vuoto esistenziale percepito. La modalità di relazione tipica è rilevabile anche al di fuori del rapporto di coppia: ha bisogno di continue rassicurazione e difficilmente prende decisioni autonome ma delega agli altri per la difficoltà ad assumere delle responsabilità. Il distacco non è contemplato sia perché la solitudine per il dipendente scade nel nichilismo, la realtà decade nel nulla, sia perché la relazione deve avere la forma della costrizione, l’unico modo per lui di avere garantita la sicurezza di essere con l’altro.
In cosa consiste il trattamento psicologico di una persona con dipendenza affettiva?
Il trattamento psicologico per sostenere una persona con tratti di personalità dipendente prevede il lavoro sui seguenti punti:
-
Imparare a leggere le emozioni provate anche attraverso i segnali inviati dal corpo al fine di aumentare la CONSAPEVOLEZZA di come ci si sente nella relazione;
-
Modificare lo STILE DI ATTACCAMENTO rielaborando le esperienze passate negative che conferiscono alla persona una costante percezione di insicurezza e inferiorità nei confronti dell’altro e fornire le risorse per instaurare legami rispettosi e soddisfacenti;
-
Favorire l’ASSERTIVITA’ attraverso il lavoro sui NO, riuscire a riconoscere quando è il caso di anteporre le proprie esigenze e bisogni a quelli dell’altro;
-
Migliorare l’AUTOSTIMA riconoscendo a se stessi di essere meritevoli di un amore che non faccia soffrire, imparando ad amarsi e a lasciar andare la vergogna e il lutto per riscoprire la solitudine e la fiducia in se stessi;
-
Recuperare la capacità di SCELTA attraverso l’assunzione di responsabilità e l’autodeterminazione;
-
Riscoprire la propria IDENTITA’ accettando la propria unicità e dignità.